|  L'esilio
- lungo viaggio liberatore
L'esilio
- lungo viaggio liberatore
- La terra degli scrittori -
Milan
Kundera

Vera Linhartova era negli anni '60 una delle scrittrici più ammirate in
Cecoslovacchia, poetessa di una prosa meditativa, ermetica, inclassificabile.
Dopo il 1968, avendo lasciato il proprio paese per Parigi, ha cominciato a scrivere
e a pubblicare in lingua francese. Conosciuta per la sua natura solitaria, ha
sorpreso tutti i suoi amici quando, recentemente, ha accettato l'invito dell'Istituto
francese di Praga e al colloquio consacrato alla problematica dell'esilio ha pronunciato
la sua comunicazione. E' quanto di più non conformista e di più
lucido io abbia mai letto su questo tema.
La nostra seconda metà del
secolo ci ha reso tutti estremamente sensibili al destino delle persone a cui
è stato proibito di soggiornare nel proprio paese. Questa sensibilità
piena di compassione ha avvolto il problema dell'esilio nelle nebbie di un moralismo
lacrimevole e ha occultato il carattere concreto della vita dell'esiliato che,
secondo la Linhartova, ha invece saputo spesso trasformare la sua messa al bando
in un impulso liberatore verso un altrove, sconosciuto per definizione, aperto
a tutte le possibilità.
La scrittrice, naturalmente, ha mille volte
ragione!
Come comprendere altrimenti il fatto, in apparenza sorprendente, che
dopo la fine del comunismo quasi nessuno dei grandi emigrati abbia fatto ritorno
in patria? Né Milosz, né Brandys, né Kolakowski, né
Kristeva, né Zinoviev, né Siniavski, né Skvorecky, né
Forman, né Polanski, né Agnieszka Holland, né Sylvie Richterova.
La fine del comunismo non li ha spinti a celebrare nel loro paese natale la festa
del Grande Ritorno? E se, con grande delusione del pubblico, non ne hanno sentito
il desiderio, non avrebbero dovuto almeno considerare il loro ritorno come un
impegno morale? Linhartova: "lo scrittore è prima di tutto un uomo
libero, e l'obbligo di preservare la sua indipendenza contro tutte le costrizioni
viene prima di qualsiasi altra considerazione. E non parlo di quelle costrizioni
insensate che un potere abusivo cerca d'imporre, ma delle restrizioni - tanto
più difficili da eludere quanto più sono colme di buone intenzioni
- che si richiamano ai sentimenti di dovere verso il proprio paese". In effetti
si continua a rimuginare clichés sui diritti dell'uomo e si persiste allo
stesso tempo a considerare l'individuo come una proprietà della nazione.
Ma
la scrittrice va ancora più lontano: "Ho scelto il luogo dove volevo
vivere, ma ho scelto anche la lingua che volevo parlare". Le si obietterà:
lo scrittore, quantunque uomo libero, non è il custode della propria lingua?
Non è forse questo il senso stesso della sua missione? Linhartova: "Spesso
si pretende che, più di chiunque altro, lo scrittore non sia libero di
muoversi, poiché egli è legato alla sua lingua da un legame indissolubile.
Credo si tratti ancora di uno di quei miti che servono da giustificazione alle
persone timorate...". Perché: "Lo scrittore non è prigioniero
di una sola lingua. Una grande frase liberatrice. Solo la brevità della
vita impedisce allo scrittore di trarre tutte le conclusioni da questo invito
alla libertà.
Linhartova: "Le mie simpatie vanno ai nomadi, io
non possiedo l'anima di una sedentaria. Anch'io posso dunque affermare che il
mio esilio è venuto ad esaudire ciò che da sempre era il mio voto
più caro: vivere altrove". Quando la Linhartova scrive in francese
è ancora una scrittrice ceca? No. Diviene allora una scrittrice francese?
Nemmeno. E' altrove. Altrove come un tempo Chopin. Altrove come più tardi,
ciascuno a suo modo, Nabokov, Beckett, Stravinskij, Gombrowicz. Ben inteso, ognuno
vive il proprio esilio in modo inimitabile, e l'esperienza della Linhartova è
un caso limite. Ciò non toglie che dopo il suo testo radicale e luminoso
non si possa più parlare dell'esilio come se n'è parlato fino ad
ora.
Rifugiati
nella banalit� di Massimo Rizzante
Qualche anno fa,
quando uscì su un quotidiano francese il breve testo di Milan Kundera sull'"esilio
liberatore", mi trovavo a Parigi. Avevo scelto di andarmene dall'Italia.
Nessuna dittatura mi aveva costretto a quel passo. Mi trovavo, insomma, dalla
parte più banale e meno tragica dell'esilio. Avevo letto qualche giorno
prima su una rivista, L'Atelier du roman, il saggio della Linhartova, Pour une
ontologie de l'exil, da cui Kundera prendeva le mosse per il suo intervento.
La
cosa che più mi colpì fu che la scrittrice poneva l'accento sulla
possibilità di non subire passivamente il proprio esilio, ma di trasfigurarlo,
di trasformare la propria condizione di non appartenenza in un esercizio quotidiano
di libertà. Queste parole mi ricordavano una delle non poche verità
espresse verso la fine degli anni '80 da Brodskij nella sua conferenza La condizione
che chiamiamo esilio, dove il poeta aveva affermato, con la solita sferzante lucidità,
che uno scrittore in esilio è quasi sempre "un essere retrospettivo
e retroattivo... Come i falsi profeti di Dante, il nostro uomo ha la testa perpetuamente
rivolta all'indietro e le lacrime o la saliva, gli scorrono giù tra le
scapole". Mi sembrava che Linhartova, Kundera e Brodskij, seppure con tonalità
differenti, cercassero di rivendicare il lato non tragico dell'esilio, inteso
non tanto come vagheggiamento orgoglioso e perverso del proprio passato, quanto
come potente lente d'ingrandimento degli eventi presenti, capace di osservare
i segni premonitori del futuro.
Se l'esilio assomiglia all'Inferno, pensavo,
è perché è soprattutto una scuola di chiaroveggenza e di
modestia. Allo stesso tempo mi domandai: le cose, oggi, stanno ancora così?
La tua esperienza dell'esilio può avere ancora, dopo la fine del comunismo,
qui in Europa, dei tratti comuni non dico con quella di Ovidio, Dante, Joyce,
Seferis, ma con quella dei tuoi maestri più prossimi, Kundera, Brodskij,
e di tutti quegli intellettuali che negli ultimi cinquant'anni hanno dovuto o
hanno scelto di vivere "altrove"? Per avere un altrove bisogna avere
una patria, mi dicevo. Non tanto intesa come suolo nazionale, ma come identità
storica e culturale, preziosa e incommensurabile. La banalità del mio esilio
non era dovuta all'assenza di tragicità, ma al fatto che il luogo da dove
venivo era terribilmente simile all'"altrove" in cui mi trovavo. Entrambi
questi luoghi stavano diventando interscambiali, stavano perdendo la loro specificità
storica e la loro diversità culturale. L'intera Europa stava realizzando
il suo sogno di unità. Oscuramente sentivo che un altro capitolo della
storia europea, quello dell'esilio, si stava chiudendo.
Ritornai in Italia.
Il tema dell'esilio, se non abbandonato, se ne stava in un angolo della coscienza,
silenzioso. Un fatto, recentemente, lo ha risvegliato: la lettura dell'ultimo
romanzo di Sylvie Richterova, una delle poche personalità letterarie dell'Europa
centrale che, fin dagli inizi degli Anni '70, ha scelto l'Italia, come suo paese
d'adozione. Il romanzo si intitola Second adieu ed è stato pubblicato nel
1999 in Francia da Gallimard. Tutti i personaggi della storia scrivono la loro
storia, "come se da questo dipendesse la loro vita" e la loro identità.
Credono nella parola scritta e nel dialogo che questa instaura, un dialogo errante
nel tempo e nello spazio. Tutto il romanzo è infatti un continuo partire
e ritornare, un continuo andirivieni di padri, figli, amici, amanti, lettere,
da una parte all'altra dell'Europa e del mondo: ma dappertutto lo stesso paesaggio,
la stessa indefinibile frontiera tra bellezza e squallore, tra passato e futuro,
lo stesso presente "unico e definitivo" senza un altrove spaziale o
temporale dove andare o dove ritornare.
I personaggi della Richterova vivono
l'esilio come una condizione ormai acquisita, inalienabile, permanente: annunciano
la definitiva banalità dell'esilio, ho pensato. Le loro teste, come quelle
dei falsi profeti di Dante, sono rivolte all'indietro, ma quello che vedono in
realtà è ciò che sta loro davanti. Il loro eterno errare
sarebbe quello degli odierni turisti del globo, se essi non fossero animati da
quell'ansia di "nascondere scrupolosamente" la loro vita segreta, se
non fosse per quell'ostinato e irresistibile istinto di darle forma. Sono esuli
che incarnano l'addio a un'epoca, quella in cui l'esilio poteva essere ancora
compreso come castigo o liberazione.
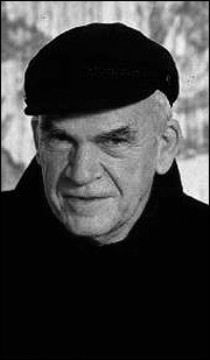 Milan Kundera
Milan Kundera
 Successivo Successivo
 IBRIDAZIONI IBRIDAZIONI
 Pagina
precedente Pagina
precedente
|